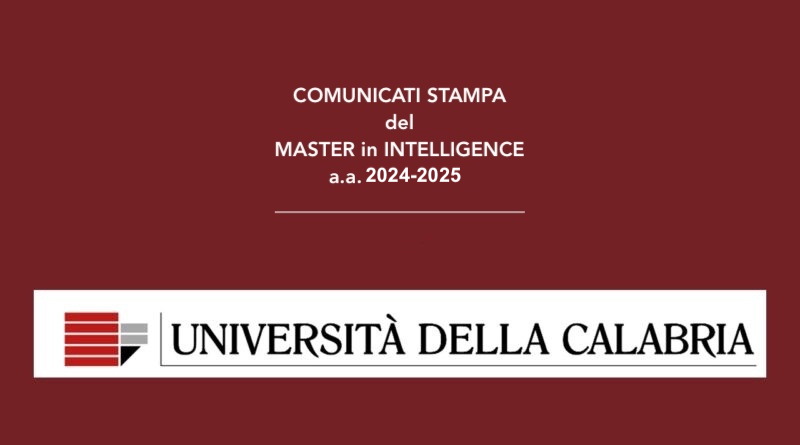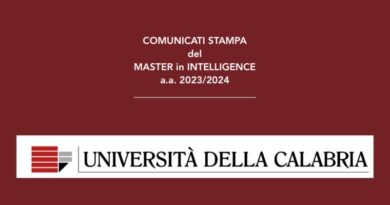INTELLIGENCE: Alberto F. De Toni al MASTER DELL’UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA: “L’Intelligence come strumento per interpretare la complessità del presente e del futuro”.
RENDE (1.4.2025) – Capire la complessità e anticipare il futuro è il titolo della lezione tenuta da Alberto Felice De Toni, già rettore dell’Università di Udine e presidente del Comitato ordinatore della Scuola Superiore ad ordinamento speciale delle Difesa, al Master in Intelligence dell’Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri.
Per De Toni, il mondo della realtà è un sistema altamente complesso e caotico. La complessità è sempre esistita e continua ad aumentare. Per governare questo cambiamento è necessario predisporre strumenti che permettano alle organizzazioni di convivere con le inevitabili trasformazioni.

La lezione si è articolata su due argomenti: complessità e anticipazione del futuro, in inglese foresight (anticipazione).
È importante differenziare i termini inglesi forecast e foresight: i modelli di previsione (forecast) sono basati sulla proiezione in avanti delle esperienze passate, mentre i modelli dell’anticipazione (foresight) comportano la costruzione di scenari possibili, che considerano la molteplicità dei presenti, i segnali deboli, trend emergenti e possibili percorsi di evoluzione.
A livello scientifico la scoperta della complessità risale convenzionalmente al 1972, anno di pubblicazione su Science dell’articolo More is different del premio Nobel per la fisica Philip W. Anderson (1923 – 2020). Quest’ultimo analizza criticamente il metodo cartesiano analitico o riduzionistico, che parte dall’assunto che esaminando l’infinitamente piccolo è possibile comprendere l’infinitamente grande.
Il primo passo è ridurre il problema in piccole parti, da risolvere in modo indipendente. Ricostruito l’insieme, si procede con la risoluzione complessiva del problema.
L’approccio cartesiano, afferma Anderson, non è capace di spiegare le emergenze derivanti dalle interazioni tra le parti. Anderson evidenzia quindi una serie di fenomeni che non possono essere ridotti in parti elementari separate, perché agendo in questo modo si perderebbe la proprietà chiave che caratterizza il sistema. Lo studioso americano sostiene che esistono dei fenomeni in cui la proprietà non appartiene a nessuna delle singole parti, ma è frutto dell’interazione tra le parti stesse. Si pensi all’acqua, dove a temperatura ambiente l’H2O si caratterizza per il suo stato liquido, mentre i suoi componenti idrogeno e ossigeno si trovano nello stato gassoso. Pertanto, la liquidità dell’acqua non è una proprietà delle singole parti, ma il risultato della loro interazione.
Altro esempio è la percezione cromatica: le particelle elementari sono prive di questa proprietà, ma l’interazione tra atomi e luce genera il fenomeno visivo che chiamiamo colore.
Anderson si sofferma sulla proprietà emergente che si verifica quando un numero di entità semplici, dette agenti, operano in un ambiente, dando origine a comportamenti più complessi in quanto collettività. Tale fenomeno si riscontra in ambito fisico, biologico e sociale.
In ambito fisico si pensi alla sincronizzazione dei metronomi, una creazione di ordine dal disordine. Se l’entropia misura il grado di disordine di un sistema, è la neghentropia o entropia negativa che indica un ordine che emerge dal caos.
Anche la nascita della vita è una creazione di ordine. Nel nostro universo abbiamo sia una costante creazione di disordine, sia l’azione dei sottosistemi che dal basso creano ordine. Ogni essere vivente è un essere neghentropico che crea ordine ed emette disordine all’esterno.
Gli stormi sono un altro esempio di creazione di ordine. Un numero di agenti semplici (gli uccelli) danno origine a comportamenti più complessi (volo in stormo) per aumentare le loro probabilità di sopravvivenza rispetto ai rapaci. Si applica l’assioma che regole semplici (semplicità) creano comportamenti complessi (complessità) necessari alla sopravvivenza (resilienza).
In ambito sociale, il volume Social Emergence: Societies as Complex Systems di Keith Sawyer, afferma che le società sono sistemi complessi adattativi. Anche i sistemi sociali emergono dal basso, dall’incontro di individui, i quali man mano costruiscono strutture articolate come città e Stati.
Che i processi di emergenza siano tipici dei sistemi sociali lo dimostrano anche i distretti industriali, sistemi che nascono prima come processi di interazione sociale per diventare cognitivi e, infine, economici.
De Toni si è quindi soffermato sugli schemi per gestire sistemi semplici, complicati, complessi e caotici.
I sistemi semplici possono essere affrontati ricorrendo a soluzioni “confezionate”, perché si sono già rivelate efficaci (protocolli).
I sistemi complicati possono essere affrontati mettendo in atto un approccio analitico-cartesiano e adottando lo schema “analisi-pianificazione-implementazione”. Nei sistemi complessi il fenomeno non dipende dalle singole parti, ma dalle loro relazioni e rende perciò necessario adottare un approccio sistemico mediante lo schema: “azione-apprendimento-adattamento”.
De Toni ha concluso ribadendo che il futuro non può essere previsto, ma può essere anticipato. E per anticipare il futuro sono necessari approcci avanzati che vadano oltre i tradizionali modelli di previsione basati sulla proiezione delle esperienze passate.
I metodi basati sulla teoria della complessità non cercano di prevedere un unico futuro, ma costruiscono diversi scenari possibili. Questo avviene analizzando le molteplici realtà presenti, prestando attenzione ai segnali deboli, identificando i trend emergenti e tracciando diversi possibili percorsi evolutivi.
L’Intelligence diventa, pertanto, uno strumento indispensabile per interpretare il presente e anticipare il futuro affrontando efficacemente la complessità intrinseca della realtà contemporanea.