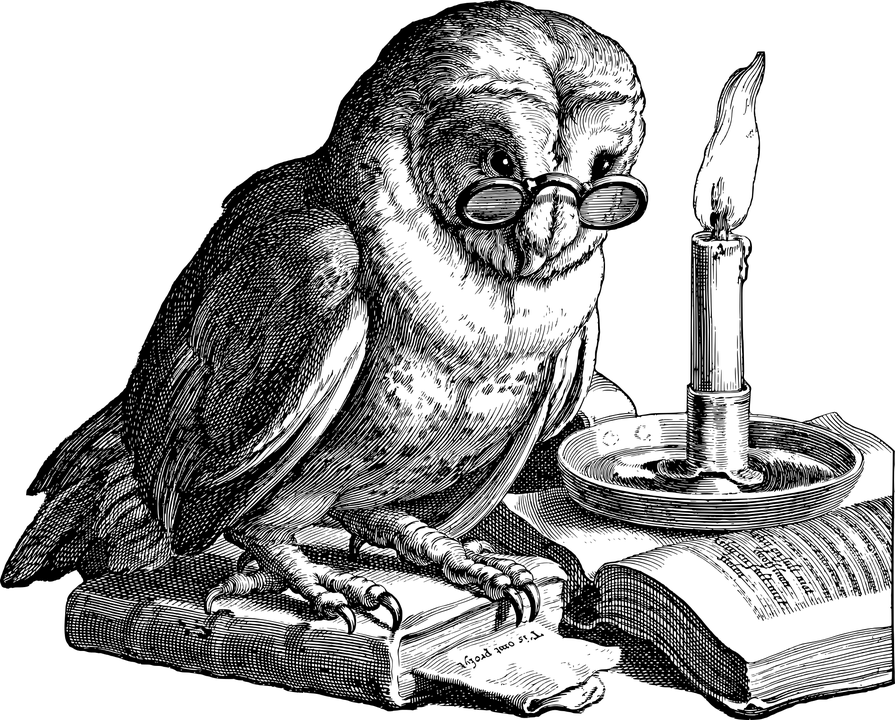Intelligenza Artificiale e Sicurezza: una nuova ontologia del controllo
Tecnologia, identità e decisione nell’era degli algoritmi: lo studio di Domenico Talia e Francesco Lopez per SOCINT Press.
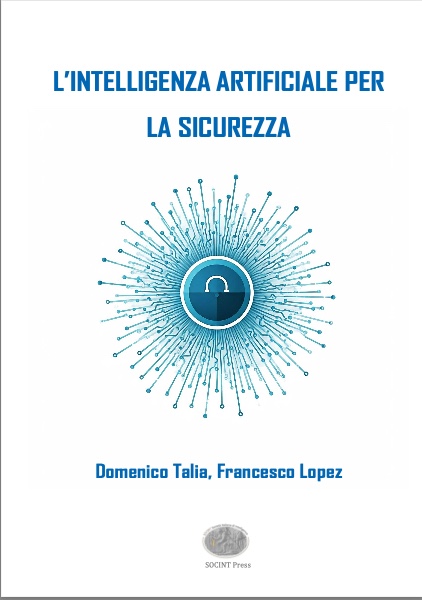
Il concetto di sicurezza si sta trasformando: non più solo questione di protezione da minacce esterne, ma intreccio di tecnologia, identità e controllo. In questo scenario si colloca lo studio Intelligenza Artificiale per la Sicurezza di Domenico Talia, informatico , ordinario di Sistemi di elaborazione delle informazioni all’Università della Calabria, e Francesco Lopez, ingegnere ambientale. Il paper, pubblicato da SOCINT Press sotto la direzione editoriale di Alice Felli, si distingue per la capacità di esplorare le implicazioni profonde dell’IA sulla società. Non si limita ad analizzare gli strumenti, ma ne svela le conseguenze culturali, politiche ed etiche, ponendo interrogativi sul futuro del potere e della libertà.
Sin dall’apertura del paper, gli autori dichiarano: “lo scopo di questo studio è descrivere il contesto tecnologico e sottolineare la multidisciplinarità, nonché l’importanza di un’area di ricerca che apre a numerosi scenari futuri di applicazione, fornendo alternative chiavi di lettura” . Questa prospettiva rappresenta uno degli aspetti più innovativi del testo, capace di connettere ambiti apparentemente distanti come cybersecurity, biometria, difesa militare ed etica.
Lo studio invita a ripensare le categorie tradizionali con cui interpretiamo il mondo.
Talia e Lopez affermano che “l’impatto dell’IA sulla difesa e la sicurezza militare” si caratterizza per “l’assenza di consenso internazionale sulle norme e le leggi che regolano l’uso responsabile” e per la dissoluzione dei confini tra sicurezza fisica e digitale. Questa trasformazione emerge chiaramente nell’analisi delle cinque funzioni chiave della cybersecurity delineate dal NIST: identificare, proteggere, rilevare, rispondere e recuperare. Queste dimensioni non sono più compartimenti stagni, ma elementi dialoganti di un nuovo paradigma di sicurezza integrata.
L’intreccio tra IA, biometria e IoT – descritto dagli autori come “una combinazione molto utile per sicurezza, affidabilità, accuratezza e usabilità” – suggerisce un’evoluzione del concetto stesso di protezione. Essere sicuri, in un mondo dove fisico e digitale si compenetrano, non significa più difendersi da minacce isolate, ma gestire un ecosistema complesso e interconnesso.
Uno dei passaggi più stimolanti riguarda la biometria comportamentale. Gli autori scrivono che “l’identificazione basata sulla biometria comportamentale considera i movimenti catturati dai sensori degli smartphone, analizza la velocità di battitura, la dinamica dei tasti e i movimenti del mouse” , sollevando interrogativi profondi sulla natura dell’identità.
Se questi sistemi “garantiscono un’autenticazione continua”, allora l’identità non è più un’essenza statica ma un flusso dinamico. Siamo davvero ciò che facciamo? Se un’IA può riconoscerci meglio di un essere umano sulla base dei nostri pattern comportamentali, cosa implica questo per la conoscenza di sé e degli altri?
Il testo offre un’analisi originale della trasformazione della temporalità nell’era dell’IA applicata alla sicurezza. Il ciclo decisionale di Boyd viene esaminato nella sua capacità di “entrare nel loop dell’avversario guadagnando un vantaggio competitivo” . L’accelerazione dei processi decisionali ha implicazioni che vanno oltre l’ambito militare, come dimostra l’esperimento della DARPA in cui un F-16 pilotato da IA ha sconfitto ripetutamente un pilota umano con manovre impossibili da sostenere.
Mentre le macchine comprimono il tempo decisionale, gli esseri umani potrebbero aver bisogno di più spazio per la riflessione. Il testo sottolinea l’urgenza di sviluppare “approcci proattivi e adattivi in grado di rilevare vulnerabilità e tracciare minacce informatiche”, in un contesto in cui la velocità di risposta può fare la differenza tra sicurezza e vulnerabilità.
Il concetto di guerra a mosaico elaborato dalla DARPA viene interpretato dagli autori come un nuovo modello strategico basato su piattaforme modulari e interconnesse Gli sciami di droni, alcuni armati di testate esplosive e dotati di comportamento auto-organizzante, rappresentano un paradigma di intelligenza collettiva emergente.
Questo modello tecnologico riflette anche la condizione dell’individuo nell’era digitale: una realtà sempre più frammentata e modulare, dove il controllo e l’autonomia sono in costante ridefinizione.
Un passaggio particolarmente rilevante riguarda la divergenza tra l’approccio europeo e quello statunitense sull’uso dell’IA in ambito militare. Gli autori osservano che “malgrado i benefici derivanti dall’introduzione dell’IA, gli Stati Uniti adottano un approccio meno restrittivo rispetto all’Europa, che manifesta preoccupazione per l’impiego di LAWs (Lethal autonomous weapons) senza un completo controllo umano” .
Mentre gli USA puntano sull’innovazione tecnologica senza troppi vincoli etici, l’Unione Europea insiste sul ruolo dell’IA come “supporto al processo decisionale, evitando di ledere i diritti fondamentali dell’uomo”. Questa divergenza si inserisce in uno scenario geopolitico complesso, dove la governance dell’IA potrebbe diventare un fattore strategico decisivo.
Un aspetto affascinante è l’Adversarial Machine Learning, ovvero la capacità di manipolare i sistemi di IA alterando gli input per ottenere risultati specifici. L’uso di dati biometrici falsi, riconoscimenti vocali alterati e malware offuscati dimostra come la sicurezza non sia solo una questione tecnologica, ma anche epistemologica: in un mondo dominato dagli algoritmi, come distinguere il vero dal falso?
Nelle conclusioni, il volume apre a una prospettiva interdisciplinare in cui “i sistemi di IA, le neuroscienze, le biotecnologie e il calcolo quantistico costituiranno il punto di partenza di nuove innovazioni”. Questa visione suggerisce che la sicurezza del futuro non sarà solo un problema informatico, ma un intreccio tra biologia, fisica e intelligenza artificiale.
L’Intelligenza Artificiale per la Sicurezza si distingue per la capacità di intrecciare riflessione teorica e analisi tecnica, delineando un quadro in cui la sicurezza è questione di protezione, ma anche una dinamica fluida tra identità, tempo e controllo.
Il volume si chiude con un monito: “stabilire standard condivisi sulle norme che regolano droni, veicoli e sistemi d’arma letali potrebbe costituire un elemento decisivo per il rispetto dei diritti umani” . Un richiamo a una responsabilità collettiva nel determinare il futuro della sicurezza nell’era dell’intelligenza artificiale.