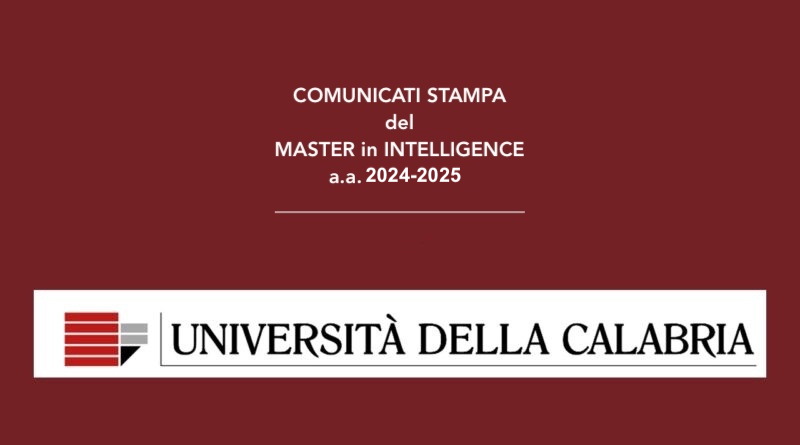INTELLIGENCE, ROMANO BENINI AL MASTER DELL’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA: “L’INTELLIGENCE DEL POTERE CORTIGIANO E DEL FUTURO ARTIGIANALE. STUDIARE A FONDO PER CAPIRE IL MONDO”.
(Rende, 19.4.2025) L’Italia cortigiana è il titolo della lezione tenuta da Romano Benini, docente alla Link Campus University e saggista, al Master in Intelligence dell’Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri.

Benini, esperto di politiche del lavoro e autore di numerosi saggi sul sistema produttivo italiano, ha proposto una lezione sul tema del potere, partendo da un concetto fondamentale: ognuno è plasmato dai condizionamenti della vita, poiché le scelte dei singoli sono sempre indotte da fattori esterni e chi ne è consapevole acquisisce un vantaggio strategico, considerando che la maggior parte delle persone è convinta di essere libera benché, in realtà, sia condizionata da forze esterne.
Il docente si è quindi soffermato sul carattere cortigiano del potere italiano e sulle decisioni indotte dai “persuasori occulti”. Di conseguenza, ha analizzato la complessa relazione tra i diversi poteri presenti in Italia, utilizzando categorie interpretative specifiche per descrivere le caratteristiche del sistema sociale, economico e politico del nostro Paese.
L’Italia si è distinta nei secoli grazie al sapere artigiano che ha rappresentato la capacità di generare prodotti caratterizzati da bellezza e qualità, arrivando oggi a rappresentare circa il 25% dei beni di lusso globali, percentuale destinata ad aumentare secondo le proiezioni economiche più recenti. Questo potere è profondamente radicato nel patrimonio di competenze e creatività italiano, sviluppato attraverso secoli di tradizione manifatturiera.
Si tratta di un potere artigiano che, di fatto, costituisce un soft power che si oppone al potere cortigiano, quest’ultimo rappresentato dalla mala politica, dai favoritismi, dalla corruzione, dal clientelismo e dalla burocrazia inefficiente.
Benini ha quindi evidenziato come il potere economico italiano sia stato storicamente limitato da quello politico, generando dinamiche caratterizzate da alternanze tra innovazione e inefficienza, tra sviluppo e stagnazione.
Non possedendo grandi risorse naturali, l’Italia ha investito nella capacità di trasformazione dei materiali, creando un sistema economico unico nel panorama mondiale, che spesso è entrato in conflitto con le dinamiche burocratiche e cortigiane, le quali ne hanno impedito una piena valorizzazione delle potenzialità. Queste dinamiche sono poi esplose con la cosiddetta “finanza creativa”, caratterizzata da operazioni speculative e poco trasparenti, che è stata un tallone d’Achille per il Paese.
Per Benini esiste un rapporto corrosivo tra potere cortigiano e potere generativo, nel momento in cui il primo prevale orientando un’economia fondata sul capitale simbolico e culturale. In questo modo, mentre prima il cittadino era riconosciuto per il lavoro che faceva, ora invece è riconosciuto principalmente per la sua capacità di spesa e di consumo.
Il docente ha riflettuto sulle radici storiche di queste dinamiche, citando esempi significativi: del periodo romano, con la liberazione degli schiavi che diventano imprenditori; del Medioevo, con l’emancipazione dalla servitù della gleba; dei nostri giorni, dove le partite IVA sono aperte in prevalenza da cittadini extracomunitari, sottolineando così la continuità di schemi sociali ed economici attraverso i secoli.
Benini ha quindi messo in rilievo l’importanza della consapevolezza storica e culturale come elemento cruciale per comprendere le attuali sfide economiche e politiche, poiché, come ha ricordato citando una massima nota, “chi non conosce la storia non sa di cosa ha bisogno”.
Pertanto, conoscere i meccanismi del potere italiano significa comprendere la relazione autentica tra potere economico e politico che genera comunque fenomeni corruttivi, in quanto queste due forme di potere si alimentano reciprocamente, nel bene e nel male.
Il docente si è soffermato sulla globalizzazione, caratterizzata dal ruolo crescente della finanza rispetto alla produzione manifatturiera, sostenendo che la crisi attuale derivi dalla prevalenza della logica finanziaria e cortigiana su quella produttiva e generativa, indebolendo – speriamo in modo non irreversibile – la capacità di innovazione e sviluppo in Italia.
Di conseguenza, ha collegato questi argomenti al concetto di intelligence, definendolo come capacità predittiva basata sulla raccolta accurata e sull’analisi multidisciplinare delle informazioni disponibili.
La capacità di prevedere e comprendere i fenomeni economici e politici, nella sua opinione, dipende dalla curiosità intellettuale, dall’approccio critico e dalla comprensione profonda delle dinamiche storiche e culturali, elementi fondamentali per orientare decisioni strategiche a livello nazionale e internazionale.
Ha poi affrontato il tema centrale dell’intelligenza artificiale e di strumenti come ChatGPT, evidenziando come questi sistemi raccolgano spesso informazioni poco attendibili dal web, producendo risultati di qualità non sempre affidabile.
Di fronte a queste realtà tecnologiche, il docente ritiene necessario puntare sull’intelligence per potenziare l’intelligenza umana, che deve sviluppare una capacità di analisi critica, ponendosi una domanda fondamentale: perché?
La ricerca del “perché” trova risposta nella capacità di connessione umana dal profondo al superficiale, applicando una cultura multidisciplinare, necessaria per comprendere realmente la natura degli eventi contemporanei.
Attualmente siamo in una fase di crisi e di cambiamento epocale, e dobbiamo essere capaci di superarla utilizzando la fondamentale capacità predittiva dell’intelligence.
Benini ha concluso citando Antonio Gramsci (1891-1937): “Il vecchio mondo sta morendo. Quello nuovo tarda a comparire. E in questo chiaroscuro nascono i mostri”, sottolineando l’attualità di questa riflessione nel contesto geopolitico contemporaneo.
Da qui la necessità che l’Intelligence riesca a produrre consapevolezza globale, esaltando la curiosità intellettuale e la capacità di conoscere profondamente gli altri e le diverse culture.
E in definitiva, ha concluso Benini, “non siamo più in grado di prevedere il cambiamento perché abbiamo smesso di studiare”, evidenziando l’importanza della formazione continua e dell’approfondimento culturale in un’epoca di trasformazioni sempre più rapide e complesse.