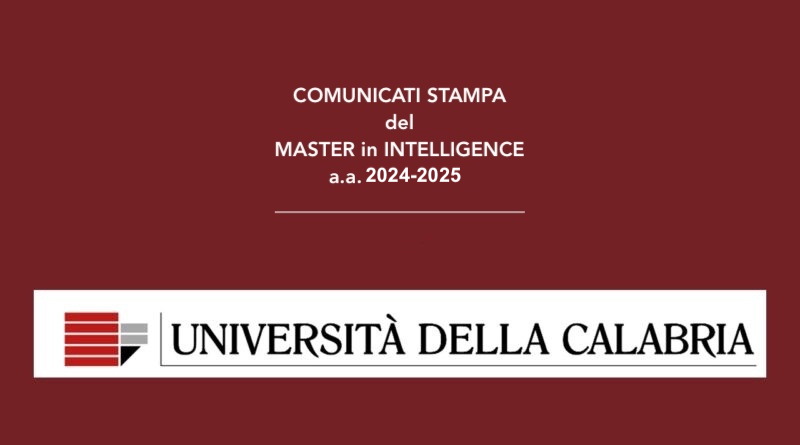INTELLIGENCE, ALBERTO PAGANI AL MASTER DELL’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA: “LA DISINFORMAZIONE È UN’ARMA CONTRO LE NAZIONI”.
Rende (8.4.2025) – Intelligence e disinformazione è il titolo della lezione tenuta da Alberto Pagani, professore dell”Università “Alma Mater” di Bologna e deputato nella XVII e XVIII legislatura, al Master in Intelligence dell’Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri.
Pagani ha trattato il tema della disinformazione, indagando cause e conseguenze nella società attuale.

La disinformazione ha come obiettivo l’inganno di cittadini, decisori politici e apparati di Intelligence, inducendoli a prendere decisioni e ad agire in modo diverso da come farebbero se avessero accesso alla verità dei fatti. Per questo motivo, gli apparati di sicurezza devono sviluppare la capacità di identificare le campagne di disinformazione siano esse orchestrate da Stati ostili o all’interno dei confini nazionali.
Storicamente, la disinformazione è sia rivolta all’esterno sia all’interno: uno dei primi esempi è rappresentato dai Protocolli dei Savi di Sion, un falso documento creato dall’Ochrana, la polizia segreta zarista, nei primi anni del XX secolo. Questo testo, pubblicato per la prima volta nel 1903 e spacciato come il verbale di una riunione segreta tra i leader dell’ebraismo mondiale, descriveva un presunto complotto ebraico per il controllo globale attraverso la manipolazione della finanza, dei media e delle istituzioni democratiche. In realtà, si trattava di un plagio di vari testi preesistenti, come dimostrato dal Times nel 1921, assemblato per fomentare l’odio antisemita e giustificare i pogrom nell’Impero russo. Nonostante la sua comprovata falsità, questo documento ha avuto un’influenza devastante: è stato utilizzato dalla propaganda nazista, è stato diffuso in mezzo milione di copie da Henry Ford (1863-1947) negli Stati Uniti e continua ancora oggi a circolare in ambienti di estrema destra e in alcune aree del Medio Oriente, dove viene strumentalizzato per attacchi politici contro Israele e i valori progressisti.
Il secondo caso riguarda il Volantino di Villarjuif,, apparso in Italia nel 1976, che conteneva una falsa lista di additivi alimentari presentati come cancerogeni. Il documento, attribuito a un sedicente ospedale oncologico di Parigi, indicava come pericolose sostanze del tutto innocue: clorofilla, cellulosa, caramello, acido citrico. La diffusione di questa notizia, amplificata dai media che pubblicarono acriticamente le informazioni, obbligò il vero Centro Oncologico di Villejuif a smentire ufficialmente. Nonostante la rettifica, il documento continuò a diffondersi tramite fotocopie passate di mano in mano, creando seri problemi ad aziende come la Campari. Malgrado la smentita delle autorità sanitarie, la notizia falsa continuò a circolare, dimostrando come una disinformazione ben costruita possa sopravvivere nel tempo persino quando viene scientificamente confutata.
Un terzo esempio è rappresentato dal caso di Andrew Wakefield, gastroenterologo britannico che nel 1998 pubblicò su Lancet, una delle più autorevoli riviste scientifiche, un articolo che suggeriva un legame tra vaccino trivalente contro morbillo-parotite-rosolia e insorgenza dell’autismo. Sebbene lo studio fosse basato su appena 12 casi, le dichiarazioni di Wakefield, durante una conferenza stampa, scatenarono un’ondata di panico tra famiglie in tutto il mondo. La notizia si diffuse rapidamente, sollevando notevoli preoccupazioni pubbliche. Nel 2010, dopo un’indagine approfondita, Wakefield venne radiato dall’albo dei medici per ‘condotta non etica e disonestà, essendo emerso che aveva falsificato i dati per tornaconto personale, avendo ricevuto compensi da avvocati impegnati in cause contro case farmaceutiche. Lancet ritirò l’articolo, definendolo “fraudolento”. Nonostante le numerose smentite scientifiche, secondo uno studio del 2009, un americano su quattro continuava a credere che i vaccini causassero l’autismo, dimostrando come una notizia falsa ma emotivamente potente possa radicarsi nell’opinione pubblica per decenni, minando la fiducia nelle istituzioni scientifiche.
La negazione/denial e l’inganno/deception sono due strategie complementari nella disinformazione. Il denial consiste nell’occultare informazioni bloccando i canali a cui un avversario potrebbe accedere, creando un quadro informativo lacunoso che compromette l’analisi del nemico. Spesso è talmente efficace che gli analisti non sono nemmeno consapevoli di ciò che ignorano. La deception, invece, è un’azione attiva che manipola la realtà, diffondendo deliberatamente informazioni false per indurre l’avversario a impiegare in modo svantaggioso le proprie risorse. Mentre la prima strategia nasconde la verità, la seconda crea una realtà alternativa per influenzare i processi decisionali dell’antagonista. Storicamente considerato moralmente deprecabile, l’inganno è stato spesso relegato tra quelli che Tacito definiva “arcana imperii” gli strumenti occulti del potere. Durante la Seconda guerra mondiale, infatti, molte operazioni furono condotte in questo modo, contribuendo al successo degli Alleati. Celebri sono le operazioni Mincemeat, Bodyguard ed Esercito fantasma.
Quando si costruisce un’operazione di inganno bisogna, innanzitutto, definire e individuare l’obiettivo della campagna, studiando le debolezze degli antagonisti.Gli obiettivi, in ogni caso, devono manipolare gli avversari su intenzioni, capacità e attività; proteggere le informazioni sensibili; ottenere vantaggi strategici e influenzare i processi decisionali della controparte.
Le campagne di disinformazione sfruttano il bisogno di consenso delle élite politiche, per cui colpiscono l’opinione pubblica e non il decisore politico direttamente. Il decisore politico tenderà poi a conformarsi con il sentiment dell’opinione pubblica.
La disinformazione può essere orientata anche all’interno del proprio Paese per motivi strategici. A tale riguardo, si potrebbe citare la fake news della fabbrica austriaca di saponi, prodotti con il grasso dei soldati francesi e inglesi caduti, per motivare l’opinione pubblica francese a sostenere gli sforzi bellici nel primo conflitto mondiale.
Le operazioni psicologiche sono pianificate in maniera strategica.
Le tecniche sono disinformazione, occultamento, depistaggio, psyops e cyber deception.
Il medium attraverso cui vengono veicolati i messaggi di disinformazione è a sua volta il messaggio, data la capacità del mezzo di modellare la percezione ed il comportamento umano. Come ricordato dal filosofo e sociologo tedesco, Jürgen Habermas, il giornale all’inizio del Novecento era il mezzo di comunicazione della società di massa, mentre la televisione riguardava un consumo più familiare che adottava un linguaggio maggiormente diretto. Il contesto e il modo in cui si forma l’opinione pubblica dipendono dal medium dominante, che determina la logica comunicativa.
Il focus della lezione si è poi spostato sull’analisi dei social media, divenuto oggi il canale predominante per la trasmissione delle comunicazioni. All’interno di questo ecosistema digitale, il 20% degli utenti produce l’80% dei contenuti, in una dinamica di relazioni prevalentemente orizzontali. Questo modello favorisce la rapida diffusione di contenuti virali caratterizzati da un elevato impatto emotivo, a discapito di informazioni più equilibrate e verificate. La comunicazione sui social si basa sul micro-targeting, che tende a profilare gli utenti in base alle preferenze manifestate durante la navigazione, creando bolle informative che limitano l’esposizione a prospettive diverse dalle proprie. Tale meccanismo rafforza preconcetti e pregiudizi, facilitando la polarizzazione delle opinioni e alimentando la disinformazione. In questo contesto si sviluppano camere d’eco/echo chamber che sfruttano le vulnerabilità cognitive innate: l’attenzione sempre più frammentata, il bias di conferma che ci porta a cercare solo informazioni che confermano le nostre convinzioni, e la tendenza al conformismo sociale che amplifica comportamenti collettivi anche quando irrazionali.
Tutto ciò rende l’applicazione di tecniche manipolatorie e propagandistiche particolarmente efficace, soprattutto nel contesto della società della disinformazione, obbligando gli Stati e gli apparati di sicurezza a cercare soluzioni adeguate e innovative per tutelare la sicurezza delle istituzioni e la libertà dei cittadini.